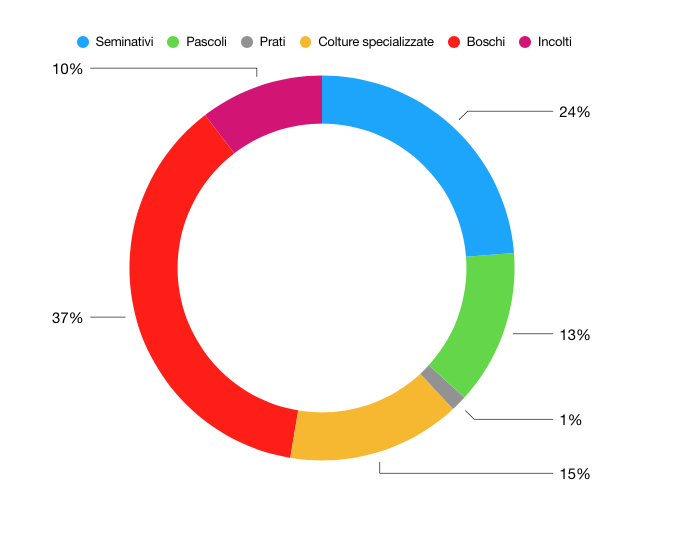la cantina è in rivoluzione; il mosto sta procedendo: nel silenzio del mondo si sente il bollore della magia della trasformazione: zuccheri che diventano alcool…
non posso perdere tempo nemmeno oggi
anche oggi devo agire, ossigenare, muovere le bucce, affondare il cappello premendo sul follatore
devo annusare, guardare, ascoltare, assaggiare…la fermentazione procede, i profumi inebriano, l’anidride si sparge nell’aria ed io non posso fermarmi…
misura, spilla, muovi, cambia, annota…un giorno dopo l’altro nella corsa che porta dall’uva al mosto, da mosto al vino
ho le mani appiccicose e le dita nere, è lo zucchero che dalla vendemmia ti penetra la pelle, è il colore dell’uva che di prende e ti conquista e che diventa parte di te
ho le dita nere, il segno dell’intimo matrimonio tra me, l’uva, il mosto e il vino: il frutto del matrimonio tra me e la terra
ma ora sono qui, con le dita nere e preparo qualcosa per gli amici che verranno: il lardo, affumicato con il ginepro, sarà ottimo per i nostri vini, affetto il salame che viene dai campi all’orizzonte della vigna e dispongo il formaggio che viene dalla valle
sono le piccole cose che raccolgo dagli amici, pronte a fare conoscere alla piccola fetta di mondo che decide di passare da qui
e sarà bello confrontarsi, condividere, notare le impressioni, valutare le espressioni
è un po’ freddo oggi e non è l’ideale bere il rosso così freddo, ma la stagione è questa, si sentiranno di più i tannini, ma non so se chi verrà a degustare lo capirà, ma non importa, anche questo fa parte della vita
non so nemmeno come ha fatto a trovarmi, chi decide, non sapendo dove andare di prendere una strada che non porta quasi a nulla per venire a trovare me, nel mio paradiso
vedranno le dita nere, ma in questi giorni respireranno il mosto
a volte di inizia con un po’ di freddezza, a volte prevale la timidezza, qualcuno addirittura è un po’ guardingo nel valutare quello che dico, ma finisce sempre con un abbraccio, con la promessa di tornare, tutti consapevoli che le ore passate insieme e attorno ad una bottiglia di vino sono in fondo una fetta di vita che entra nel bagaglio di ciascuno di noi
vedono le dita nere, perché ho messo le mani nel mosto, nelle bucce e nel vino e lo zucchero mi è entrato nella pelle, arrivando nell’anima come il profumo del primo vino
quando verso il vino il silenzio prepara l’attimo della degustazione: in fondo sono venuti qui per questo, per conoscere il mio vino, non per conoscere me
forse ne venderò un po’
è l’atto finale del lungo processo della mia passione ma vorranno sapere di tutto, come è fatto, cosa faccio, come avviene, cosa avviene, i trucchi, i segreti, come evolve, come fosse possibile spiegare davanti a un piatto e a un po’ di vino il miracolo della vita, il miracolo della natura
mi chiederanno cose che non ricorderò: i giorni di fermentazione, l’età della barrique, la temperatura di una certa fase: a volte non ricordo, qualche volta non lo so
qualcuno arriverà all’essenza del miracolo che entra nel bicchiere e solo pochi capiranno, nel loro intimo, che io ho solo fatto il guardiano di un processo antico che non ha bisogno di altro se non del tempo, della pazienza e della passione
mi chiederanno quale è il vino che preferisco dei miei: quale annata, quale vitigno, ma non ho mai risposta, so solo raccontare la stagione del vino: il vino che viene dall’uva che ha preso più sole, quello che ha preso talmente tanta grandine che ancora arrabbiato, il vino che si è fatto aspettare e il vino che verrà
ci sarà pure un vino migliore dell’altro, quello più buono, quello venuto meglio, si, lo so, ma non riesco veramente a rispondere a una domanda così
…molti capiscono, molti no, qualcuno mi parlano del difetto che ogni tanto scorgono nel bicchiere di quel particolare sapore, del fatto che qualche mese prima era diverso oppure solo qualche minuto fa…
io so perché è così, so quale scelta in quel momento quel vino ha preso quella strada, forse era la sua strada, forse anche la mia, ed è allora che penso che alla fine ogni vino abbia un senso, per buono e cattivo che sia, e soprattutto penso che il vino, quel vino, non solo sia frutto della vigna della stagione e del lavoro del vignaiolo, ma quando viene bevuto diventi il compimento del ciclo della vita
di tutte quelle persone rimarrà qualcosa del loro passaggio, come a loro rimarrà qualcosa del tempo passato qui